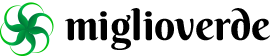di DAMIÁN ARABIA
Per molto tempo, il liberalismo ha commesso un errore che il mondo oggi sta pagando caro. Credeva che bastasse gestire o applicare determinate politiche. Nel frattempo, altri hanno capito qualcosa di più profondo. Che le società non si muovono solo per numeri, ma per simboli, emozioni e senso storico. In una parola, per cultura.
Il risultato è stato evidente. Mentre il liberalismo si rifugiava in papers, tecnicismi e dibattiti chiusi, la sinistra ha avanzato con enorme efficacia sul terreno culturale. Il cinema, il teatro, la musica, le università, i media e persino il linguaggio quotidiano sono stati occupati da una visione del mondo statalista, collettivista e profondamente diffidente verso l’individuo. Non perché fosse migliore, ma perché nessuno la contestava.
Quel vuoto culturale è stato segnalato con chiarezza da Axel Kaiser nel suo libro “La fatal ignorancia“, dove descrive l’anoressia culturale delle destre e dei liberalismi. Una rinuncia quasi volontaria a combattere sul piano delle idee, della filosofia, della sociologia e del senso comune. Mentre il liberalismo si concentrava sulla gestione e sull’economia, altri costruivano un’egemonia culturale. E quando quell’egemonia è installata, le riforme economiche rimangono sempre a portata di decreto per essere rovesciate.
 In questo contesto irrompe Javier Milei come un’anomalia storica. Per la prima volta, assume un presidente liberale libertario con piena consapevolezza che la disputa culturale è centrale. Non si limita a governare. Scrive, spiega, polemizza e argomenta. La sua produzione intellettuale, insolita per qualsiasi presidente argentino contemporaneo, non è decorativa né autobiografica. È dottrinale. Libri come El camino del libertario o El fin de la inflación puntano a stimolare il buon senso e il senso comune, collegare economia con etica e politica, e offrire un quadro concettuale che va ben oltre la congiuntura del momento.
In questo contesto irrompe Javier Milei come un’anomalia storica. Per la prima volta, assume un presidente liberale libertario con piena consapevolezza che la disputa culturale è centrale. Non si limita a governare. Scrive, spiega, polemizza e argomenta. La sua produzione intellettuale, insolita per qualsiasi presidente argentino contemporaneo, non è decorativa né autobiografica. È dottrinale. Libri come El camino del libertario o El fin de la inflación puntano a stimolare il buon senso e il senso comune, collegare economia con etica e politica, e offrire un quadro concettuale che va ben oltre la congiuntura del momento.
Questo fenomeno, inoltre, non è esclusivamente argentino. Il problema che Milei ha sollevato è globale. Per decenni, il liberalismo in Occidente ha accettato una divisione implicita del lavoro. Gestire l’economia mentre altri modellavano la cultura. Così, persino in paesi con stabilità macroeconomica e crescita, il buon senso è stato colonizzato da narrative antimercato, anti-individuo e sempre più ostili all’idea di libertà. In questo contesto, l’esperienza incarnata da Milei è eccezionale anche su scala internazionale.
È una delle prime, in molte decadi, in cui un leader liberale decide di non rassegnarsi ad amministrare il possibile, ma a guerreggiare sul piano culturale, simbolico e intellettuale dove si definisce ciò che è possibile. In quel modo, non dando quella discussione di fondo, si è prodotta un’inversione silenziosa dei principi basilari del liberalismo. Si è passati da società con maggioranze che rispettano la volontà e i diritti delle minoranze, a contesti in cui minoranze organizzate hanno finito per imporre le loro agende su maggioranze silenziose. Quello spostamento non è avvenuto per imposizione autoritaria diretta, ma per assenza culturale, per aver abbandonato il terreno dove si forma il senso comune democratico.
 Come avvertì Friedrich Hayek più di mezzo secolo fa, le idee precedono le politiche e i cambiamenti duraturi avvengono solo quando si trasformano le credenze profonde di una società. Senza quella trasformazione culturale previa, o almeno simultanea, qualsiasi riforma è reversibile.
Come avvertì Friedrich Hayek più di mezzo secolo fa, le idee precedono le politiche e i cambiamenti duraturi avvengono solo quando si trasformano le credenze profonde di una società. Senza quella trasformazione culturale previa, o almeno simultanea, qualsiasi riforma è reversibile.
Forse questa è la vera novità di questo tempo. Comprendere che le riforme economiche non sopravvivono se non sono sostenute da una cultura che le capisca e le difenda. Che senza idee non c’è politica duratura, e senza discussione culturale non c’è libertà possibile. In tal senso, il fenomeno Milei non è solo un esperimento di governo, ma un punto di inflessione intellettuale. Il momento in cui il liberalismo ha smesso di limitarsi ad amministrare l’economia e ha deciso, finalmente, di battersi per il buon senso di un’epoca.
QUI L’ARTICOLO ORIGINALE – TRADUZIONE DI ARTURO DOILO